Sempre più caldo e acido: cosa sta succedendo al Mediterraneo? L’allarme del Wwf
In occasione della Giornata Internazionale del Mediterraneo, il WWF Italia lancia un allarme pressante sullo stato di salute del Mare Nostrum. Un approfondito articolo di Roberto Danovaro, professore di biologia marina all’Università Politecnica delle Marche e Presidente della Comunità scientifica del WWF Italia, pubblicato sull’ultimo numero di Panda, il magazine dell’associazione, mette in luce le “relazioni pericolose” tra la crisi climatica e il riscaldamento del Mediterraneo, definendolo un “oceano in miniatura” che si sta scaldando più di ogni altro mare.

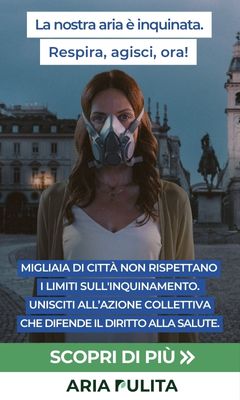
Gli oceani sono vitali per la salute del pianeta: sequestrano oltre il 40% dell’anidride carbonica, assorbono circa il 90% del calore atmosferico e producono gran parte del cibo e dell’ossigeno. Tuttavia, la loro salute è in declino. Stanno subendo un processo di acidificazione e riscaldamento accelerato, e il Mediterraneo ne è un esempio lampante, con effetti devastanti su organismi ed ecosistemi marini.
Un Mediterraneo sempre più acido e caldo: effetti degli shock termici
Il Mediterraneo è una delle regioni più sensibili all’acidificazione, con un pH diminuito fino a quasi 0,2 unità rispetto al secolo scorso, a una velocità tre volte superiore rispetto alle aree oceaniche. Questo impatta negativamente crescita, riproduzione e resistenza di molte specie, soprattutto quelle con scheletri calcarei come coralli, gorgonie e ricci di mare.
Essendo un bacino poco profondo (profondità media di circa 1,5 km contro i quasi 4 km degli oceani), le sue acque si riscaldano a tassi superiori a quelli di qualsiasi altro mare. Questo lo rende un “gigantesco laboratorio naturale” per osservare e prevedere i cambiamenti globali, come sottolinea Danovaro.
Le ondate di calore estive, con temperature che possono superare i 30-30,5°C anche a 30 metri di profondità, stanno sconvolgendo gli equilibri naturali. I “paesaggi sottomarini” cambiano drasticamente, favorendo l’ingresso di specie aliene tropicali (come microalghe, piante marine e pesci esotici dal Canale di Suez o dall’Atlantico) che prosperano in acque più calde, a scapito delle specie native del Nord-Mediterraneo che prediligono temperature più fredde.
Morie di massa, rischio carestia marina e soluzioni proposte
Le estati “super calde”, come quella del 2024, hanno già mostrato conseguenze drammatiche. Organismi sessili come gorgonie, coralli rossi e spugne subiscono un forte stress, portando a morie massive documentate in molte aree del Mediterraneo sin dalla fine degli anni ’90. Il risultato è un “panorama sottomarino desertificato”, con impatti negativi anche sulla pesca. Purtroppo, questa tendenza si sta ripresentando anche nella prima parte dell’estate 2025.
Il riscaldamento eccessivo altera anche la quantità di cibo disponibile. Le ondate di calore riducono la produzione di alghe microscopiche e macroalghe, causando una vera e propria “carestia marina“. L’ondata di calore del 2024, ad esempio, ha spazzato via molte foreste di alghe brune e praterie di Posidonia oceanica, con un recupero ancora incompleto nel 2025.
Per affrontare questa emergenza, il WWF propone due strategie chiave:
- Proteggere la biodiversità: Sistemi ricchi di specie dimostrano una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici, guadagnando tempo per ridurre l’uso di combustibili fossili.
- Restauro ecologico: Laddove la resilienza naturale non basta, è necessario intervenire con “terapie intensive” per recuperare habitat danneggiati o distrutti, una misura prevista anche dalla nuova legge europea sul restauro della Natura.
A tal fine, il WWF è partner del progetto LIFE ADAPTS, cofinanziato dall’UE, che cerca soluzioni di adattamento per specie simbolo del Mediterraneo come la tartaruga verde (Chelonia mydas), la tartaruga caretta (Caretta caretta) e la foca monaca (Monachus monachus) in Italia, Grecia e Cipro.
La salute del Mediterraneo è cruciale non solo per le specie marine, ma per l’intero equilibrio termico globale. La sua crisi è un monito urgente per l’intera vita sulla Terra.
Share this content:








