PFAS, ecco come tracciare le sorgenti degli “inquinanti eterni”. Il metodo della Sapienza
Il Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza ha sviluppato il primo metodo analitico per l’analisi isotopica dei principali PFAS presenti nell’ambiente, conosciuti come “inquinanti eterni” per la loro estrema resistenza alla degradazione. I risultati dello studio, condotto dal dottorando Eduardo Di Marcantonio e pubblicati sulla rivista Science of The Total Environment, rappresentano un passo fondamentale per il monitoraggio e la gestione ambientale di queste sostanze.
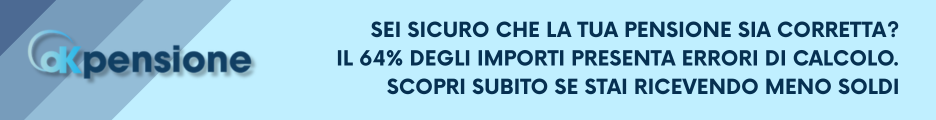
Cosa sono i PFAS e perché sono chiamati “inquinanti eterni”
I PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) sono composti chimici sintetici creati dall’uomo, presenti in numerosi prodotti come pentole antiaderenti, indumenti impermeabili, schiume antincendio, imballaggi alimentari e cosmetici. Grazie alla loro struttura chimica ad altissima resistenza al calore, all’acqua e alla degradazione biologica, si accumulano nell’ambiente e negli organismi viventi, uomo compreso, generando seri rischi sanitari tra cui effetti cancerogeni.
Il metodo isotopico per identificare le origini dell’inquinamento
Rispetto alle analisi chimiche tradizionali, l’analisi isotopica permette di distinguere le diverse fonti dei PFAS grazie alla cosiddetta “firma isotopica” che varia in base al processo di origine chimico, fisico o biologico. Dopo oltre 300 tentativi, il team ha definito un protocollo che consente di identificare le tracce specifiche di PFAS provenienti da differenti produttori industriali, distinguendo le origini anche in contesti di inquinamento diffuso e multiorigine.
Applicazioni e impatto per la tutela ambientale
Questa metodologia innovativa permette di aumentare l’efficacia nel monitoraggio e nella gestione delle contaminazioni da PFAS. Il progetto pilota, realizzato con il CNR, sta analizzando campioni provenienti dalla cosiddetta “zona rossa” in provincia di Vicenza, area particolarmente colpita da inquinamento PFAS. Il laboratorio di isotopi stabili della Sapienza, tra i più avanzati in Europa, si pone come avamposto della ricerca per la salute pubblica e la sostenibilità ambientale.
Share this content:








